Scrittura nella scissione
In Forbici di Victoria Surliuga
Adam Vaccaro
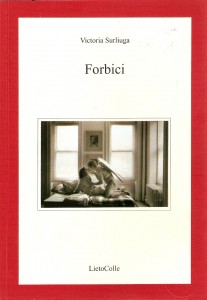
In questo libro di Victoria Surliuga – Forbici, Lietocolle, Como 2006 – la scrittura cerca e diventa arma tagliente per entrare nelle proprie scissioni, nell’attimo del delirio o della misura con la verità del proprio abisso (ab-grund). Quando l’Io è posto in tale territorio senza fondamento, fa l’esperienza di essere straniero in casa propria e può rinunciare alla sua funzione, col che la scrittura tende a rimanere dominata dall’Altro e intransitiva, da seduta psicoanalitica. Qui invece l’Io cavalca o riprende per la coda salti, vuoti logici e immagini che prorompono dall’infanzia, manifesta una forte determinazione a rinascere e resistere, contrapponendo ai tagli cuciture altrettanto impietose tra presente e passato: “tempero le matite sperando che diventino remi/ posso sfogliarle per anni seduta a scrivere/ sempre dirò le cose sbagliate a mia madre al telefono” (p.28). Non a caso è rievocato (più volte) il rapporto con la madre in lampi dischiusi tra realtà e visioni: “il terreno poteva sparire/ l’ascensore saliva in diagonale/ roteavano a lato i piani/ porte vecchie contrapposte/ torino trasuda sempre morte/ / ero un’ospite seduta sul davanzale/ con i piedi penzoloni/ mia madre si è buttata/ per anni dalla finestra/ ma i fili della biancheria sono stati il suo telone” (p.29)
Se Forbici richiamano strumento e gesto della nostra prima nascita (quel taglio di cordone ombelicale che separa e segna la costituzione della nostra specificità e differenza), nella traduzione in inglese dei testi (pp.65-82) diventano Scissors. Termine che esalta e aggiunge l’altro senso, del percorso adulto a ritroso “nell’Aperto” (sollecitato da Hölderlin ne Le liriche), nell’abisso, in cui non c’è più l’illusione del terreno solido e sicuro della ragione dell’Io a proteggerci.
Siamo stranieri in casa nostra, scissi e separati da noi stessi, ma questa separazione, che Lacan trasla in sé parere, cioè sé (pre)parare, può farsi luogo e linguaggio di autopoiesi, in cui l’Io prova a (ri)generarsi da sé. Il che gli impone la scelta: rinuncia o ripresa di sé, che in tale Aperto (regno dell’Altro) significa solo inventare attimi di ricongiunzione adiacente con l’Altro, uno spazio-tempo di rinascita, in cui “I dolori sono ignoti,/ l’amore non si impara/…/Solo il canto sulla terra/ consacra e celebra” (Rilke, I sonetti di Orfeo).
La poesia si fa così prassi di linguaggio che prova a fare i conti (im)possibili con aperture e chiusure del proprio abisso – come dire con la totalità del Sé. Quanto più la poesia fa rima con follia e cerca la misura, le tracce, la genesi dei suoi deliri, apre ed entra con occhio di sciamano nelle sue viscere di non senso qualche risalita di (un nuovo) senso. Che solo l’Io, pure temporaneamente estromesso, può ritrovare.
In tal caso, la scrittura non può che svolgersi tra salti violenti e vuoti irreparabili. Scrittura dunque nel tra, della e nella scissione, di attraversamento oscillante tra irrisioni e pietas “della casa degli orrori di un luna park”, in cui “gli ospiti vorrebbero sapere se basta nascondersi/ sotto ai liquori del bar per sfuggire ai vampiri/ forse bisogna informarli che hanno denti cariati/ ma soprattutto della marca da bollo/ se uno vuole uscire da una delle cinque porte” (p.50). Sapori di ridicolo e grottesco temperati a tratti da tenerezza: “noi donne costruiremo microscopici/ santuari ai gatti grigi dei nostri ex/ non avremo vent’anni tutta la vita/…/ come oche saltellanti sulla zampa destra/ tagliuzzata da un vetro pulito” (p.51). Le forbici tagliano e la cucitura è di un altro pianeta. Se vuoi – sembrano dire – prova a farla tu che leggi. Noi, se vuoi rischiare, ti lasciamo la porta aperta. Il percorso è nel dolore e nel gelo che blocca: “il gelo percorreva/ i capelli impolverati/…/ dita intirizzite sulle tempie/ si paralizzavano i neuroni” (p.48); “della sua pazzia sospettavo/ ogni freddo natale dai tetti innevati” (p.49). L’inferno non è fatto di fiamme ma di ghiaccio in cui è scolpito l’angelo caduto. Che nel cuore rivela rabbia, sdegno e insofferenza per i buoni modi dell’ipocrisia borghese, come nel testo di p.55: “con certe facce da schiaffi/ i piccioni del duomo se la tiravano/ nell’attraversare la piazza/ feroci e impettiti come signore bene/ deluse della loro borsa nuova/ un falso cartier/ riparata in boutique/ / un divertimento fatto di noia/ lo stesso dei colombi/ cannibali frustrati/ privi di una prima colazione/ a base di signore felici/ con in mano i coltelli/ della loro tagliente educazione”.
L’inferno e il male non sono dunque astratti e metafisici, ma hanno genesi illuminate per lampi nelle esperienze vissute nel qui e ora storico. Svelano l’era glaciale umana in cui siamo, genesi comune e fonte di senso degli inferni privati. Per questo, alla fine, è tanto dentro di sé da toccare tratti di ognuno e di tutti, della fatica di camminare in un deserto ghiacciato, tra “…onde di sabbia/ portate dal nulla che incenerisce” (p.49), dentro e oltre la famiglia. Un ossimoro che non cancella, anzi esalta, la memoria assalita dai brividi insanabili del dolore delle perdite, che qui si fa, però, utero insostituibile del desiderio di un altro futuro: “mai ce l’avrebbe fatta nel mondo senza insulti” (p.33).
