Libri
del Mese
![]()
torna
indietro all'indice dei Libri del Mese
"Letteratura e pubblicità "
di Francesco Ghelli
Carocci Editore, Roma 2005 – pp 127 – E 9,00
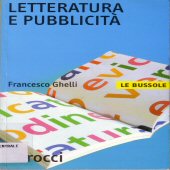
Il libro del mese -Ottobre-Novembre 2005
Fabiano Alborghetti
L'incontro con la pubblicità
(o reclame secondo il termine in voga ai tempi del carosello) è
giornaliero, meno accade con la letteratura ma entrambe - secondo Francesco
Ghelli che svolge attività didattica e di ricerca presso l'Università
di Bologna nonché studioso di letterature comparate - nascono dalla
medesima radice anche se appartengono a due "discipline" e mondi
distinti, lontani. Mentre la letteratura è scritta per durare,
la pubblicità ha un ciclo di vita molto breve: la letteratura (quale
che sia il genere - poesia, narrativa etc...) offre testi, messaggi coerenti
e organizzati, nei quali è possibile riconoscere l'intenzione dell'autore.
Inoltre, leggere è un fatto privato, volontario, un'azione che
si compie "in dialogo" tra il libro/autore ed il fruitore/lettore
grazie ad un isolamento dalla realtà circostante.
La pubblicità ci coglie invece in ogni momento della giornata,
spesso contro la nostra volontà, vive della ripetizione che a livello
subliminale trova radice tra i sottofondi compositi ed informi con una
forma di fruizione distratta eppure penetrante.
I testi di letteratura sono riconoscibili per lo stile (di un poeta, di
uno scrittore, di un saggista) ma è quasi impossibile riconoscere
una precisa firma all'interno di un messaggio pubblicitario che spesso
è opera di un team di creativi (o copywriters) mentre un libro,
un testo letterario è (tranne le raccolte collettanee, antologiche
o meno) opera di un solo autore. Cosa accomuna allora letteratura e pubblicità?
Nonostante i molti distinguo che ogni lettore potrà e vorrà
trovare, è indubbio che le due discipline hanno dato vita, negli
ultimi anni, ad un serrato dialogo. Il libro di Francesco Ghelli prende
in esame gli ultimi duecento anni con la più ampia mappa di implicazioni
possibili a cavallo di più letterature (francese, inglese, italiana,
americana) e si serve di più contributi: retorica, teoria letteraria,
storia della letteratura, storia dell'arte, studi storici, culturali e
semiotici sulla pubblicità.
Sottolinea anche l'Autore che effettivamente è scarsa la bibliografia
specifica sul tema letteratura e pubblicità. Note e riferimenti
si trovano su testi specifici di pubblicità (consiglierei anche
Confessioni di un Pubblicitario di David Ogilvy o Il Mestiere del Copywriter
di Alastair Crompton, senza dimenticare i testi offerti dai pubblicitari
Lorenzo Marini e Jacques Seguela, quest'ultimo noto soprattutto per la
campagna elettorale che fece vincere a Chirac le elezioni presidenziali).
Il libro di Ghelli condensa agilmente una lunga serie di studi, sviluppandosi
in tre capitoli che cito riprendendo dall'introduzione dell'autore stesso
perfettamente analitica. Nel primo capitolo viene seguito il dibattito
teorico su letteratura e pubblicità (analogie fra i due linguaggi
dal punto di vista della retorica e teoria letteraria; la controversia
secolare sul presunto statuto "artistico" della pubblicità;
l'accostamento della pubblicità al sacro: riflessioni e rappresentazioni)
Nel secondo capitolo sono analizzati gli interscambi fra i due fenomeni
(influssi della letteratura sulla pubblicità come linguaggio da
imitare, come deposito di valori estetici utili alla nobilitazione, e
vendita, dei prodotti); si ricordano gli scrittori prestati alla pubblicità,
con particolare attenzione al caso italiano ed alla tradizione di mecenatismo
aziendale.
Nel terzo capitolo infine vengono esaminate le rappresentazioni della
pubblicità nell'immaginario, dal Settecento ai giorni nostri. L'intento
(riuscito) dell'Autore è quello di trattare la letteratura come
testimonianza significativa delle fasi di sviluppo dell'intreccio pubblicità/civiltà
dei consumi.
Chiude il testo una attenta sezione bibliografica che consiglio a chi
volesse approfondire l'argomento anche se la maggior parte dei riferimenti
citati è di ambito anglosassone.
Oltre che essere un libro particolarmente scorrevole a fine lettura persisterà
lo sconcerto incredulo della potenza che ambiguamente la pubblicità
esercita sia sull'immaginario collettivo (plasmato per mode e bisogni)
che sulla letteratura che lentamente e inesorabilmente arriva a riconoscere
nell'immediatezza comunicativa della pubblicità un più sicuro
metodo penetrativo (vedi le Headlines - la prima linea, il "telegramma"
che determina se chi legge continuerà la lettura del testo pubblicitario).
Accade cosi che non sia solo la pubblicità ad attingere dalla letteratura
ma che la letteratura attinga dalla pubblicità per rendersi più
riconoscibile e vendibile, con la coscienza che sul lessico (non solo
familiare ma anche dotto) oggi esercita più influenza che in passato
l'obiettivo di una più efficace e rapida fruizione. Il fascino
dell'oscuro non attrae più, anche nella poesia alta: anche questo
è un effetto interattivo del linguaggio pubblicitario?
Da vari sondaggi è stato ormai assodato che i lettori che si fermano
(o si limitano) a leggere le Headlines sono cinque volte più numerosi
di quanto leggono la Body Story (o testo del messaggio pubblicitario).
Siamo abituati a recepire un concetto da una stringa di parole, omettendo
di leggere quanto segue perché presumiamo di averlo indovinato
(e spesso è vero perché a questo punta la pubblicità:
calamitare l'attenzione velocemente e convincendo). Proprio questa velocità
di lettura (o non lettura) è alla base della caduta d'interesse
del più vasto pubblico nei confronti della letteratura, troppo
esosa e onerosa per tempi di attenzione e fruizione. Ha senso e si può
immaginare un altro equilibrio tra letteratura o pubblicità? O
ciò che conta è solo il peso, il valore, di ciò che
si fruisce?
Fabiano Alborghetti